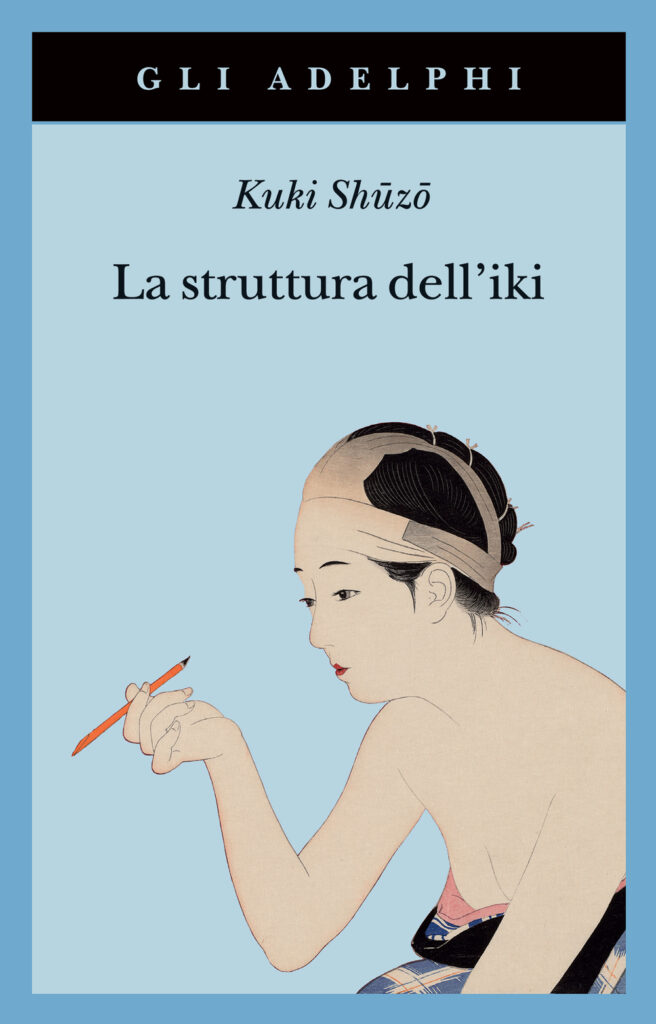Ho spesso notato come in genere i giapponesi che conosco si vestano in modo semplice, ma elegante, con tagli e colori non troppo accesi; allo stesso modo nei negozi e nelle riviste più popolari l’eleganza è sobria, raffinata, contenuta. Mi sono sempre chiesto quale ne fosse il motivo.
La risposta è in una parola: Iki.
Il concetto di Iki non ha un equivalente diretto in altre lingue, perché esprime un concetto unicamente legato al contesto socio-culturale giapponese. Per semplificare, si potrebbe tradurre come “semplice eleganza, seduzione raffinata”.
Appartiene al mondo dell’estetica giapponese: un approccio sottile alla bellezza, che enfatizza l’eleganza, la raffinatezza, ma attuato con naturalezza e senza ostentazione.
Nasce in Giappone durante il periodo Edo, nel XVII secolo. La nuova classe dei Chōnin – ricchi cittadini mercanti – aspirava a distinguersi attraverso un comportamento che suggerisse non solo l’eleganza, ma anche un sottile distacco dalle restrizioni confuciane più rigide (tipiche della nobiltà e dei samurai). Era quindi un elemento di originalità che si manifestava soprattutto attraverso la moda, le arti e l’etichetta quotidiana; l’accento era posto sulla raffinatezza senza sforzo e su un fascino che andava oltre la mera bellezza esteriore o l’ornamento.

Il più evidente esempio di Iki è sicuramente il taglio del kimono: come lo conosciamo oggi è la forma che nacque proprio in quel periodo per mettere in mostra la raffinatezza e la compostezza di chi lo indossava. Erano realizzati in tessuti di qualità e design minimalista, spesso decorati con motivi sottili. La “seduzione raffinata” del kimono è evidente negli strati delle pieghe, con le linee a “V” che convergono verso il seno, a suggerire, senza ostentare, il corpo femminile. Ancora, dietro, il kimono lascia nuda la nuca; altro espediente per sedurre evocando.
E oggi?
Ma torniamo ai giapponesi di oggi. Nella moda contemporanea il concetto di Iki permea la gran parte del vestire quotidiano in Giappone: capi disegnati per essere discreti ma eleganti, con accessori sottili, gioielli o cappelli e persino acconciature ordinate e raffinate. L’essenza dell’Iki risiede nella sua capacità di sottrarre: non essere troppo appariscente o vistoso.
Nell’alta moda questa tradizione continua, ad esempio, attraverso stilisti come Kenzo Takada, che utilizza tessuti tradizionali in collezioni moderne. Le sue creazioni spesso fondono stampe tradizionali con tagli contemporanei.
Altri esempi di Iki si possono trovare nelle collezioni di marchi più popolari e mainstream, quali Uniqlo o Muji, dal design minimalista e funzionale.
Non è solo una moda

Ma questo ideale estetico non coinvolge solo la moda; l’arte e la letteratura esprimono sottili allusioni e una profondità emotiva che evita l’ovvio o il troppo diretto. Nel periodo Edo artisti come Utamaro e Sharaku catturavano l’essenza momentanea della bellezza e della vita urbana con una precisione quasi impressionista.

L’Iki lo si ritrova anche nel design di interni e nei giardini; in antico nelle case dei mercanti si creavano spazi che erano al tempo stesso esteticamente piacevoli e pratici: “meno è più”, che è poi diventato una componente fondamentale dell’architettura e del design giapponesi moderni.

Altri esempi sono in antico la villa imperiale Katsura a Kyoto con le sue linee che favoriscono una connessione senza soluzione di continuità con la natura e con l’uso di materiali naturali che invecchiano graziosamente. Oggi il 21_21 Design Sight a Tokyo, progettato da Tadao Ando, dalle sue linee pulite e cemento grezzo, si fonde con l’ambiente circostante, esempio di semplicità e raffinatezza. Anche il designer Naoto Fukasawa, i cui prodotti sono celebri per la loro semplicità intuitiva e funzionale, è un esempio moderno di Iki.
Sotto il kimono: “La Struttura dell’Iki” di Kuki Shūzō
L’Iki è ben più di un ideale estetico, di moda o design: “Capire l’Iki è come percepire la fragranza di un’intera civiltà” scriveva Giovanna Baccini, che ha curato l’edizione italiana de “La Struttura dell’Iki” di Kuki Shūzō (Adelphi, collana i peradam, 1992).
Questo testo, fondamentale per chi voglia approfondire la cultura giapponese, esplora il tema dell’Iki non solo come concetto estetico ma come riflessione filosofica profonda sulla cultura e l’identità giapponese.
Il filosofo e scrittore Shūzō Kuki individuò tre elementi nell’iki: una seduzione inquietante, una forza spirituale che mantiene distanti e una rinuncia ai giochi consueti dell’amore passionale.
Il suo lavoro mostra in dettaglio come l’Iki si manifesti attraverso l’aspetto, il comportamento e la percezione sociale e propone una visione complessa di come questa estetica influenzi e sia intrecciata con la vita quotidiana della civiltà giapponese. L’autore collega l’iki alla spontaneità e al distacco e suggerisce che queste qualità sono centrali per la comprensione anche dell’estetica giapponese contemporanea.
Nel saggio Shūzō il termine Iki sarebbe caratterizzato da una spontaneità controllata, un distacco emotivo e una sofisticata semplicità. Note fondamentali ne sarebbero l’ambiguità, il paradosso, e la sottigliezza, sia nelle interazioni sociali sia nell’arte e nella moda. L’Iki si manifesta così nell’equilibrio tra il desiderio non detto e l’espressione di tale desiderio, creando una tensione raffinata e una sorta di eleganza spontanea. Ad esempio, un comportanto “Iki” sarebbe quello in cui i gesti e le parole vengono scelti e controllati per esprimere emozioni senza però travolgerle. L’idea di non cedere completamente ai propri sentimenti, mantenendo un certo livello di riservatezza ed eleganza, è fondamentale per l'”iki”. In ciò si può trovare molto dell’etica anche del Giappone moderno, per cui le emozioni non sono mai espresse, ma – più che represse – comunicate in modo indiretto e controllato.
Il saggio di Shūzō continua ad essere una lettura fondamentale per chiunque sia interessato a comprendere le sfumature uniche dell’estetica giapponese e il suo impatto sulla vita quotidiana e sull’arte.
Per concludere
La continuità nel mondo moderno dell’iki come concetto estetico dimostra la sua intrinseca adattabilità e la sua profonda risonanza con i valori culturali giapponesi; così, come per molte, le vecchie tradizioni possono trovare nuova espressione in un mondo che cambia rapidamente.